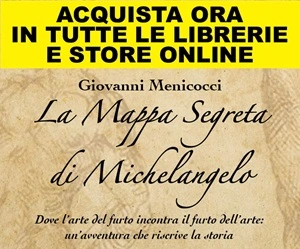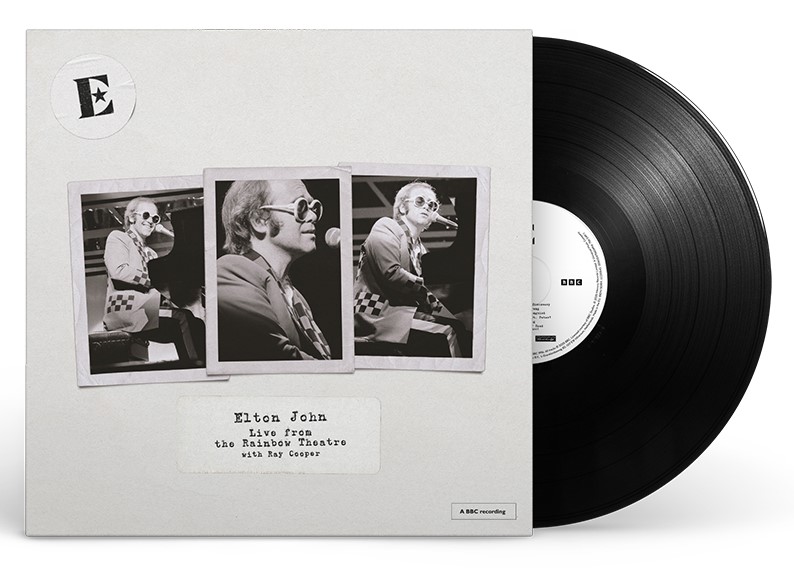Ascanio Celestini, intervista.
Cinema / Intervista - 25 July 2025 07:00
Come un musicista che cambia la scaletta a ogni concerto pescando dal proprio repertorio

Ascanio Celestini Celestini scrive, interpreta e dirige il suo primo spettacolo nel 98’, dal titolo: Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini. Racconta il rapporto tra padre e figlio durante un viaggio, dove il primo racconta le proprie esperienza e prepara l’abbandono. Da cosa nasce l’idea di un viaggio segnato da una connotazione pasoliniana per spiegare l’asprezza della vita in un salto generazionale tra padre e figlio?
In quel periodo ero ancora indeciso se continuare l’università, studiare antropologia e fare ricerca sul campo a tempo pieno. Mi interessavano soprattutto i racconti orali e in particolare fiabe e storie di vita. Per questo i primi due intervistati sono stati mia nonna che raccontava storie di streghe e mio padre che parlava della guerra, di come l’aveva vissuta un bambino che non aveva compiuto dieci anni. Ma in questo lavoro di studio sentivo che mi mancava qualcosa. Quei racconti erano significativi nel loro contesto, quando li raccontava la persona che li aveva vissuti o che, almeno, li aveva sentiti raccontare da altre persone che vivevano la narrazione nella sua dimensione orale, domestica, sentita profondamente. Dal momento che passavano a me… io li analizzavo come un bambino che smonta il giocattolo per capire come funziona il meccanismo. Ma quando smonti il giocattolo: non ci puoi più giocare. Nel teatro ho trovato la maniera di rimontare il giocattolo per continuare a giocarci. Oggi i racconti che raccolgo posso farli vivere ancora in una situazione di oralità che è il teatro. E, di conseguenza, imparare a scrivere mantenendo un po’ di quel profumo di oralità anche quando le storie passano dalla voce al libro. I miei primi spettacoli sono stati fiabe che cercavano di nutrirsi di parole contemporanee. Quello spettacolo che si ispirava alla scrittura di Pasolini, soprattutto quello che ancora spera di trovare una vitalità fertile nel mondo rurale e nelle borgate del sottoproletariato urbano, è stato il mio primo approccio al mondo del poeta simbolo dell’impegno intellettuale nel nostro ‘900.Anche in “Milleuno” lei racconta l’esistenza di chi vive ai margini della società e della capitale in particolar modo. Tratta di sovente temi sociali e storici, come l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Quanto conta la memoria collettiva, sociale, storica, nelle sue opere?
Non credo che esista una memoria collettiva. Sarebbe un ossimoro. La memoria è personale. Poi ognuno di noi può metterla a disposizione degli altri, condividere, confrontarsi, scontrarsi. Ma proprio la storia dell’azione partigiana di Via Rasella a Roma il 23 marzo del ’44 e la rappresaglia nazifascista alle cave Ardeatine ci ricorda che le memorie sono tante e che non è possibile trovarci tutti d’accordo. La riconciliazione non passa per l’omologazione delle memorie, ma può farci acquisire una coscienza civile che ci porta a seppellire l’ascia di guerra senza dimenticare che abbiamo avuto visioni del mondo diverse. Che continueremo a avere utopie diverse, ma che non è opportuno scannarsi. E che, in fin dei conti, quando scoppia un conflitto (bellico, sociale, ideologico…) quelli che rischiano di più e pagano il conto più alto sono gli ultimi. Come scrive Pasolini nell’intervento al congresso dei radicali del ’75 (che purtroppo è stato letto da altri poiché il poeta era appena stato ammazzato) che tra i compiti dell’intellettuale c’è quello di «considerare, infine, incontrovertibile e fuori da ogni discussione il fatto che, tra gli sfruttati e gli sfruttatori, gli infelici sono gli sfruttati».Celestini non è soltanto teatro ma anche cinema. Nel 2006 interpreta il ruolo di Padre Cavalli in “Mio fratello è figlio unico” di Daniele Luchetti. Ha un aneddoto da raccontare ai fa di quell’esperienza?
È stata un’esperienza veloce. Un paio di giorni sul set. Tante persone che si muovono. Qualcuno riesci a capire cosa sta facendo, ma altri sembra che vadano vagando senza meta, in attesa di essere chiamati per fare qualcosa. L’impressione è stata che il film ce l’avesse in testa solo il regista. Che molti avessero le migliori intenzioni per fare un buon lavoro, ma con poca condivisione. Si facevano gli scherzi. Mi ricordo di uno che girava con una bottiglietta di plastica piena d’acqua. Gli aveva fatto un buchetto e schizzava l’acqua sulla patta dei pantaloni di artisti e tecnici per simulare che se l’erano fatta addosso. A me non piace la goliardia e anche per quel che riguarda il mestiere sono abituato a lavorare con il minimo indispensabile di sapere tecnico. Ci deve essere, è un presupposto indispensabile, ma poi ci vuole passione e anche una visione del mondo, non solo della propria opera o, in generale, dell’arte. Come scrive Pasolini: passione e ideologia. Non come «concomitanza, ossia: Passione e nel tempo stesso ideologia" e non solo come “endiadi (passione ideologica o appassionata ideologia)”». Ma «nel senso che pone una graduazione cronologica: "Prima passione e poi ideologia", o meglio "Prima passione, ma poi ideologia”».In “La pecora nera” da lei diretto nel 2010, lei racconta l’esperienza di un giovane vissuto in manicomio, ambientato negli anni Sessanta. Ripercorre le tappe della vita del protagonista e pone un confronto tra i “Santi” - così chiamati dal protagonista - presenti nella struttura, in rapporto alla società. Per La pecora nera lei ha ottenuto diversi riconoscimenti. A distanza di quindici anni come valuta il disagio vissuto da Nicola? Lei ha parlato di speranza del protagonista di riconoscersi nel proprio disagio. Oggi come allora, in relazione all’attuale complessità sociale o burocratica, è ancora valido questo concetto secondo lei?
Quando ho cominciato la mia ricerca sul campo per la scrittura della Pecora Nera ero convinto che le grandi rivoluzioni colpiscono le grandi istituzioni. Ma di tutte le istituzioni moderne quasi nessuna è stata davvero colpita a morte o almeno delegittimata. Ce le siamo portate tutte nel nuovo millennio: carcere, caserma, scuola, famiglia, eccetera. L’unica che è stata letteralmente smontata è il manicomio. Tra gli anni sessanta e ottanta del novecento hanno spalancato le porte, abbattuto le recinzioni attorno ai padiglioni, tirato giù i muri e aperto i cancelli. Come diceva Basaglia c’era bisogno di distruggere il lager per cominciare a curare i malati. Ma il manicomio più pericoloso è quello che abbiamo nella testa, nello sguardo per l’altro. Non è stato il manicomio a creare la barbarie dell’internamento, ma la cultura dell’internamento a creare il manicomio con le sue mura, porte chiuse a chiave e pseudo cure criminali come l’elettroshock e la lobotomia. Dunque, come dice lei nella domanda, “oggi come allora” dobbiamo sforzarci di vedere la complessità pirotecnica dell’essere umano dietro la staticità del suo disagio. Sia fuori che dentro le istituzioni.C’è un regista un attore a cui Celestini si è ispirato negli anni della propria formazione?
I miei riferimenti sono Martina, Argentina, Luciano, Paride, Dimma, Otello, ma anche mia madre, mia nonna, mio padre. Io imparo a raccontare dalle persone che non scrivono e, possibilmente, nemmeno leggono. Persone che raccontano una storia solo quando ne sentono veramente il bisogno, perché è la loro storia e non possono farne a meno. Gregory Bateson fa l’esempio delle rondini che migrano per migliaia di chilometri. Se le osserviamo possiamo prendere atto della perfezione del loro volo, «ma rimaniamo pressoché all’oscuro del modo in cui lo fanno». Dunque «la sola maniera in cui le rondini possono trasmetterci questa informazione è mediante gli errori che compiono e il modo in cui li correggono». I grandi scrittori non fanno errori. Da loro posso imparare poco e rischio continuamente di mettermi nella loro scia e copiarli. Con un narratore occasionale e domestico riesco a vedere il meccanismo in trasparenza. Tra i pochi intellettuali e artisti dai quali credo di avere imparato qualcosa ci sono quelli che sono andati a fare ricerca tra queste persone senza letteratura. Cioè Ernesto De Martino, Pier Paolo Pasolini e Giovanna Marini.Chi è Ascanio Celestini? Quali hobby o passioni coltiva fuori dalla professione artistica?
Ho avuto la fortuna, ma anche la maledizione, di sposare un’arte che avrei frequentato anche se non fosse diventato il mio lavoro. Se avessi fatto il restauratore come mio padre avrei comunque letto tanto, sarei andato al cinema e a teatro. Forse avrei scritto senza l’opportunità di pubblicare. Ma poi la mia passione è diventata un’attività professionale. Non sempre la sovrapposizione funziona, ma non mi posso lamentare.Il prossimo progetto di Ascanio Celestini?
Il prossimo progetto è portare in tournée Poveri Cristi. Non solo la trilogia Laika-Pueblo-Rumba da rappresentare di seguito in più serate, ma anche serate singole per le quali decidere, di volta in volta, quali storie raccontare. Così capiterà che farò anche per più giorni di seguito dei Poveri Cristi diversi. Una sera la storia di Domenica e quella della Vecchia, un’altra quella del razzista e dell’immigrato, un’altra ancora la Donna con la testa impicciata e la Prostituta. Come un musicista che cambia la scaletta a ogni concerto pescando dal proprio repertorio. Credito foto Davide Scimone© Riproduzione riservata